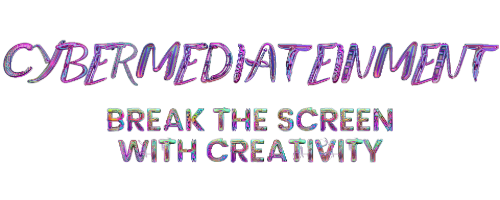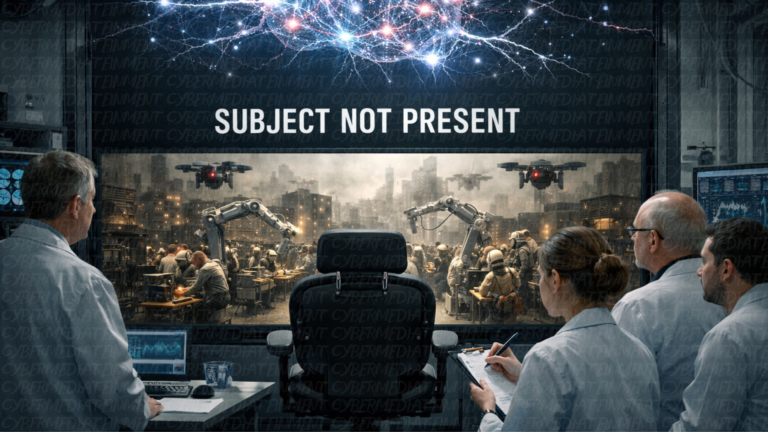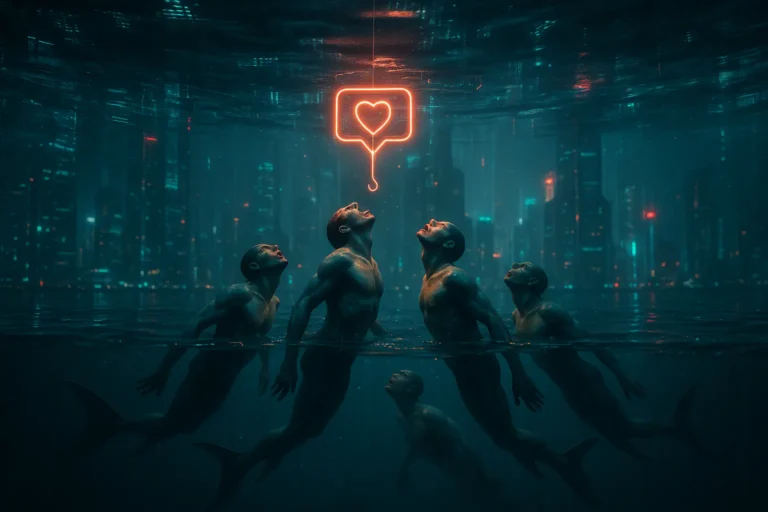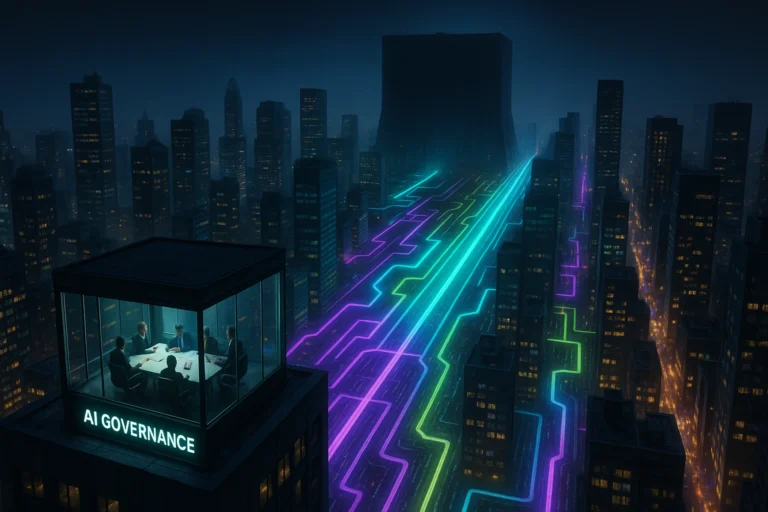Zuckerberg vs Altman: chi controlla l’intelligenza che useremo
Nel 2025, l’intelligenza artificiale non è più promessa tecnologica ma campo di battaglia economico e geopolitico. Due figure dominano questo scenario con strategie radicalmente opposte: Mark Zuckerberg, che costruisce cattedrali computazionali fatte di data center e GPU, e Sam Altman, che tesse alleanze miliardarie e racconta una missione planetaria. Non è semplice rivalità imprenditoriale — è scontro tra due modelli di controllo sull’infrastruttura cognitiva del futuro. Uno accumula ferro computazionale che sopravviverà a qualsiasi collasso speculativo. L’altro costruisce consenso attraverso partnership strategiche e aperture tattiche. La domanda non è chi vincerà, ma quale architettura di potere determinerà come miliardi di persone interagiranno quotidianamente con sistemi di intelligenza artificiale.
Siamo dentro una bolla speculativa che ricorda le dot-com del 2000 e le criptovalute del 2021 — momenti dove innovazione reale e febbre finanziaria si intrecciano producendo vincitori strutturali e macerie di promesse non mantenute. Nel primo semestre 2025, i finanziamenti all’AI negli Stati Uniti hanno toccato 104 miliardi di dollari — equivalente al PIL annuale di paesi come Ungheria o Kuwait — con un incremento del 75% rispetto all’anno precedente. Eppure, secondo ricerche del MIT, il 95% dei progetti pilota di AI generativa implementati dalle aziende non produce ritorni economici misurabili. È il classico pattern della bolla: euforia generalizzata, capitale che insegue qualsiasi cosa etichettata “AI”, valutazioni disconnesse da fondamentali, pochi attori che costruiscono asset reali mentre la maggioranza brucia risorse in sperimentazioni senza sbocco.
La guerra per i cervelli: poaching e ideologia
Il primo fronte di confronto riguarda il capitale umano — ma non nel senso HR tradizionale. Stiamo parlando di scienziati e ingegneri che pubblicano su Nature e NeurIPS, che hanno inventato architetture di rete citate migliaia di volte, che comprendono matematica dell’ottimizzazione a livelli che solo poche centinaia di persone al mondo padroneggiano. Questo talento è risorsa più scarsa delle GPU e più strategica dei brevetti.
Negli ultimi mesi Meta ha intensificato campagne di reclutamento con offerte economiche senza precedenti storici. Secondo fonti Reuters, tra i nomi corteggiati c’è Alexandr Wang, fondatore di Scale AI — startup di annotazione dati valutata 14 miliardi che fornisce infrastrutture critiche per l’addestramento di modelli. Sam Altman ha accusato pubblicamente Meta di strategia “mercenaria”, arrivando a citare bonus di ingaggio nell’ordine dei 100 milioni di dollari per singoli ricercatori top-tier. Meta ha smentito la cifra specifica, ma la sostanza della contrapposizione resta: per Zuckerberg il talento è asset da acquisire attraverso compensazione economica superiore a qualsiasi competitor; per Altman è capitale umano da trattenere attraverso senso di missione e prospettiva di contribuire a breakthrough epocale.
Questa dinamica richiama guerre del talento che hanno segnato Silicon Valley in passato — dalla competizione tra Google e Apple per designer di chip custom, al reclutamento aggressivo di ricercatori di machine learning da Baidu verso laboratori occidentali. Ma nell’AI contemporanea il fattore moltiplicativo è la potenza computazionale. Non basta avere i cervelli migliori se non hai abbastanza GPU per farli lavorare a capacità piena. Da qui il mantra che circola ossessivamente tra i leader del settore: compute per ricercatore — quanti petaflop/s di calcolo puoi mettere a disposizione di ogni singolo scienziato? È questa metrica, non lo stipendio nominale, che determina produttività scientifica reale.
L’architetto delle cattedrali computazionali
La strategia di Zuckerberg si fonda su pragmatismo radicale che ignora completamente retorica etica. Meta ha annunciato capex (capital expenditure) tra 60 e 72 miliardi di dollari solo per il 2025 — una cifra che supera il budget militare annuale di paesi come Italia o Corea del Sud. Il piano complessivo potrebbe raggiungere 600 miliardi entro il 2028, sebbene questa proiezione sia contestata come stima aggregata di settore piuttosto che impegno vincolante di Meta singolarmente. L’obiettivo dichiarato è costruire data center iperscalabili e acquisire oltre 1,3 milioni di GPU equivalenti agli H100 di Nvidia entro fine 2025 — un arsenale computazionale che rappresenta più potenza di calcolo aggregata di quanto fosse disponibile globalmente cinque anni fa.
La logica sottostante è linearmente semplice: più potenza computazionale per ricercatore significa maggiore produttività scientifica, cicli di sperimentazione più rapidi, capacità di addestrare modelli più grandi, e quindi attrattività superiore per trattenere i migliori talenti. È un circolo virtuoso materialista dove l’infrastruttura fisica — ferro, energia, raffreddamento, reti — diventa il vantaggio competitivo definitivo. Manuel Castells in “Communication Power” (2009) aveva teorizzato che nelle società-rete il potere risiede nel controllo dei nodi critici dell’infrastruttura. Meta sta letteralmente costruendo quei nodi, rendendoli proprietari, e usando quella proprietà come leva per tutti gli altri livelli dello stack tecnologico.
Questa strategia richiama la corsa alle infrastrutture del XIX secolo. Le ferrovie americane generarono una bolla speculativa monumentale che esplose nel Panic del 1873, mandando in bancarotta centinaia di compagnie. Ma le rotaie rimasero — asset tangibili che sopravvissero al collasso finanziario e divennero fondamenta dell’economia industriale successiva. Zuckerberg applica la stessa logica: anche se la bolla AI esplode domani, i data center restano, le GPU mantengono valore, l’infrastruttura può essere riconvertita. È protezione contro downside speculativo attraverso accumulo di capitale fisso.
Ma Meta non punta solo a potenza bruta. I Ray-Ban Meta Display — occhiali con realtà aumentata leggera — e i braccialetti neurali EMG che leggono segnali muscolari per controllare interfacce sono tasselli di una strategia più ampia. L’obiettivo è controllare l’interfaccia tra umano e AI, costruendo quello che Zuckerberg chiama “personal superintelligence” — un sistema che ti conosce intimamente, anticipa bisogni, media ogni interazione informativa. A questo si aggiunge la trattativa con Oracle per un contratto cloud da 20 miliardi di dollari, che permetterebbe a Meta di diversificare fonti di calcolo esattamente come Amazon trasformò AWS da infrastruttura interna a piattaforma universale che oggi genera più margine operativo del business retail originario.

Il tessitore di alleanze e narratore di missioni
Sam Altman adotta l’approccio esattamente speculare. OpenAI non trattiene scienziati con compensazioni che battono qualsiasi offerta esterna — strategia insostenibile finanziariamente per un’organizzazione che brucia miliardi operativi annui. Invece offre la prospettiva di contribuire a quello che viene presentato come breakthrough storico — la costruzione di un’intelligenza generale artificiale (AGI) che “benefici l’intera umanità”. È promessa quasi messianica: non stai solo scrivendo codice, stai plasmando il futuro della specie.
Ma la filosofia oggi si intreccia necessariamente con pragmatismo strategico. Nel 2025 OpenAI ha rilasciato i primi modelli open-weight (gpt-oss-120b e 20b) disponibili per sviluppatori — apertura tattica in risposta alla pressione competitiva di Meta che aveva reso Llama 3 accessibile gratuitamente, e di DeepSeek che aveva dimostrato che modelli addestrati con risorse limitate potevano comunque raggiungere performance competitive. Contemporaneamente i modelli più avanzati come GPT-4o restano chiusi e disponibili esclusivamente via API a pagamento, per garantire sicurezza (narrazione ufficiale) e monetizzazione (realtà operativa).
Il cuore della strategia altmaniana risiede però nelle partnership strutturali. Il progetto Stargate, sviluppato insieme a Microsoft, Oracle e SoftBank, mira a investimenti cumulati fino a 500 miliardi di dollari nei prossimi anni — cifra che supera il PIL di oltre 150 nazioni. Nel settembre 2025, OpenAI ha firmato con Oracle un contratto quinquennale da 300 miliardi per servizi di cloud computing: uno dei più grandi accordi tecnologici della storia, paragonabile solo a deal governativi per programmi militari o infrastrutturali decennali.
Parallelamente, Altman apre un fronte completamente nuovo: l’hardware consumer dedicato. Con l’acquisizione di io Products, startup fondata da Jony Ive — il designer leggendario che ha definito l’estetica Apple da iPod a iPhone — OpenAI punta a creare dispositivi AI-first per il mercato di massa, con primo lancio previsto nel 2026. È mossa che ricorda il modello Apple: integrare verticalmente software, hardware e design per controllare l’esperienza utente end-to-end e catturare margini su tutta la filiera.
Ma emerge una contraddizione strutturale sempre più evidente. La missione dichiarata di “AGI per l’umanità” si regge concretamente su contratti miliardari con big tech, funzionalità compute-intensive disponibili solo per utenti paganti Pro a $200/mese, partnership esclusive che concentrano potere anziché distribuirlo. Shoshana Zuboff in “The Age of Surveillance Capitalism” (2019) aveva documentato come le piattaforme digitali mascherassero estrazione di surplus comportamentale dietro retorica di servizio gratuito all’utenza. OpenAI opera inversione speculare: maschera accumulazione di potere computazionale centralizzato dietro retorica di beneficio universale. La tensione tra narrativa etica e necessità economiche non è bug occasionale ma feature strutturale del modello OpenAI.
Cattedrali e bazar: ritorno di una tensione fondativa
La rivalità Zuckerberg-Altman viene spesso sintetizzata nello slogan “missionari contro mercenari”. Ma se letta attraverso la storia del software, questa formula rivela stratificazioni più profonde. Nel 1997 Eric S. Raymond pubblicò “The Cathedral and the Bazaar”, manifesto intellettuale del movimento open source che contrapponeva due archetipi: la cattedrale — modello di sviluppo chiuso, centralizzato, pianificato dall’alto dove pochi eletti controllano codice e roadmap — e il bazar — spazio aperto, caotico, collaborativo dove una comunità distribuita contribuisce liberamente secondo propri interessi e competenze.
Oggi quella tensione ritorna in forma mutata. Meta/Zuckerberg incarna la cattedrale contemporanea: forza basata su capitale materiale e muri fisici — data center fortificati, GPU proprietarie, dispositivi wearable controllati end-to-end. È modello verticalmente integrato, pianificato centralmente, che punta al controllo totale della filiera dal silicio all’interfaccia utente. OpenAI/Altman si presenta retoricamente come bazar: evoca missione condivisa, apre selettivamente alcuni modelli, stringe alleanze distribuite globalmente, mobilita comunità di sviluppatori e ricercatori attraverso API e piattaforme. Non si limita a costruire prodotti ma racconta storia di partecipazione collettiva a impresa che trascende interessi commerciali individuali.
Il paragone tuttavia è imperfetto e va maneggiato criticamente. L’open source degli anni ’90 era genuino movimento dal basso — programmatori che contribuivano gratuitamente a progetti come Linux spinti da passione tecnica, ideologia libertaria, desiderio di reputazione tra pari. OpenAI resta attore istituzionale massivamente capitalizzato, legato a contratti miliardari con i più grandi monopoli tecnologici esistenti. La retorica del bazar si intreccia con la realtà materiale della cattedrale finanziaria. Come aveva intuito Castells, nelle società-rete contemporanee il potere risiede nel controllo dei “programmi” delle reti — e OpenAI, nonostante l’apertura selettiva di alcuni modelli, mantiene controllo proprietario stretto sui sistemi più avanzati e sulle partnership strategiche che determinano chi può accedere a quale livello di capacità computazionale.
Eppure il richiamo simbolico resta potente e strategicamente efficace. Come negli anni formativi dell’open source, anche oggi la narrazione di apertura diventa leva differenziante: serve a trattenere talenti che non vogliono sentirsi semplici ingranaggi di macchina estrattiva, a costruire ecosistemi di sviluppatori che contribuiscono valore senza compensazione diretta, a generare fiducia pubblica in contesto dominato da sospetto verso concentrazioni di potere tecnologico. In questo senso la formula “missionari contro mercenari” non è descrizione oggettiva di realtà ma campo di battaglia tra narrative: Zuckerberg come architetto pragmatico di cattedrali computazionali destinate a sopravvivere qualsiasi collasso, Altman come guida visionaria di movimento collaborativo globale che trascende logiche di profitto immediato.
La regolazione come terreno competitivo
A complicare ulteriormente il quadro interviene la dimensione regolatoria, che non è vincolo esterno ma diventa essa stessa terreno di vantaggio competitivo. L’AI Act europeo, entrato formalmente in vigore nell’agosto 2024, stabilisce calendario stringente con obblighi crescenti: dal 2025 trasparenza obbligatoria per modelli generali (disclosure su dati di training, capacità, limitazioni), dal 2026 regole severe per sistemi classificati ad alto rischio (audit indipendenti, documentazione tecnica dettagliata, monitoraggio post-deployment), entro il 2027 rafforzamento progressivo di compliance e sanzioni per violazioni.
Non si tratta di semplice burocrazia europea. Come già accadde con il GDPR — che da vincolo regolatorio continentale divenne de facto standard globale perché nessuna multinazionale poteva permettersi di operare con sistemi duali — anche l’AI Act può trasformarsi in modello internazionale. Le aziende che integrano proattivamente questi requisiti nei processi di sviluppo acquisiscono vantaggio competitivo su chi deve adattarsi retroattivamente. Meta e OpenAI lo comprendono perfettamente: hanno team legali e di policy compliance con centinaia di persone dedicate esclusivamente a navigare questo labirinto normativo. Ma per startup più piccole o laboratori accademici, la complessità regolatoria diventa barriera all’entrata che consolida posizioni dominanti degli incumbent. La regolazione, paradossalmente, può rinforzare concentrazione che dichiara di voler limitare.
Dopo la bolla: chi controlla l’interfaccia controlla il futuro
Altman e Zuckerberg concordano almeno su diagnosi di partenza: siamo dentro una bolla. Il primo la descrive così in intervista a The Verge: “Quando c’è un nocciolo di verità tecnologica profonda, le persone intelligenti si eccitano troppo rapidamente e le valutazioni si gonfiano oltre qualsiasi razionalità economica immediata.” Il secondo non la teme: come le ferrovie del XIX secolo che sopravvissero ai crolli speculativi perché le rotaie rimanevano come eredità tangibile, anche i suoi data center resterebbero come infrastruttura utilizzabile indipendentemente dal destino di specifiche applicazioni AI.
Ma le strategie per navigare la bolla divergono radicalmente. Meta trasforma euforia speculativa in asset fisici — GPU che mantengono valore di rivendita, data center riconvertibili per altri carichi computazionali, dispositivi wearable che creano dipendenza da ecosistema proprietario. OpenAI trasforma speculazione in consenso distribuito — alleanze che distribuiscono rischio finanziario, aperture tattiche che costruiscono lock-in attraverso ecosistemi di sviluppatori, narrativa di missione che genera supporto politico e sociale.
La storia delle bolle tecnologiche insegna pattern ricorrente: dopo il collasso, che spesso arriva quando meno previsto e per ragioni contingenti (aumento tassi di interesse, scandalo specifico, failure tecnico visibile), restano pochi vincitori strutturali che hanno costruito asset difficilmente replicabili. Nella bolla dot-com sopravvissero Amazon (che aveva costruito logistica fisica), Google (che controllava interfaccia di ricerca), eBay (che possedeva network effects delle aste). Nella bolla crypto sopravvivono exchange centralizzati (Coinbase, Binance) che controllano on/off ramp tra fiat e crypto, e blockchain con adozione istituzionale (Ethereum per smart contracts).
La domanda per l’AI non è se la bolla scoppierà — scoppierà, come tutte le bolle — ma chi controllerà l’interfaccia critica attraverso cui miliardi di persone interagiranno quotidianamente con intelligenza artificiale dopo il collasso. Sarà l’architetto della cattedrale computazionale che possiede il ferro e il design dell’hardware? O sarà il tessitore di alleanze che ha costruito ecosistemi di dipendenza distribuita attraverso API e partnership strategiche? La risposta determinerà non solo chi dominerà economicamente l’AI, ma chi avrà potere di plasmare come quella tecnologia modella cognizione, lavoro, relazioni sociali delle generazioni future. Non è questione di chi vince una competizione di mercato. È questione di quale architettura di potere — materiale o relazionale, proprietaria o ecosistemica — controllerà l’infrastruttura cognitiva del XXI secolo.
Fonti (selezione)
- Capex/GPU & compute per ricercatore: Reuters, TechCrunch, Business Insider
- Poaching & super-bonus: Reuters, Times of India
- Ray-Ban Meta & Neural Band: AP News, The Guardian
- Open-weights OpenAI: OpenAI Blog, WIRED
- Stargate partnerships: Microsoft Blog, Reuters
- AI Act timeline: Commissione UE
- Dati mercato H1 2025: Citybiz-PitchBook, MIT research on GenAI ROI