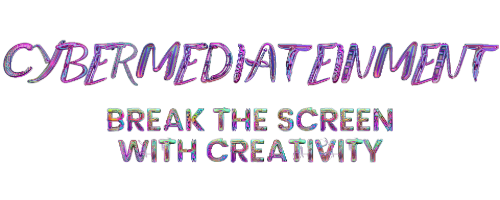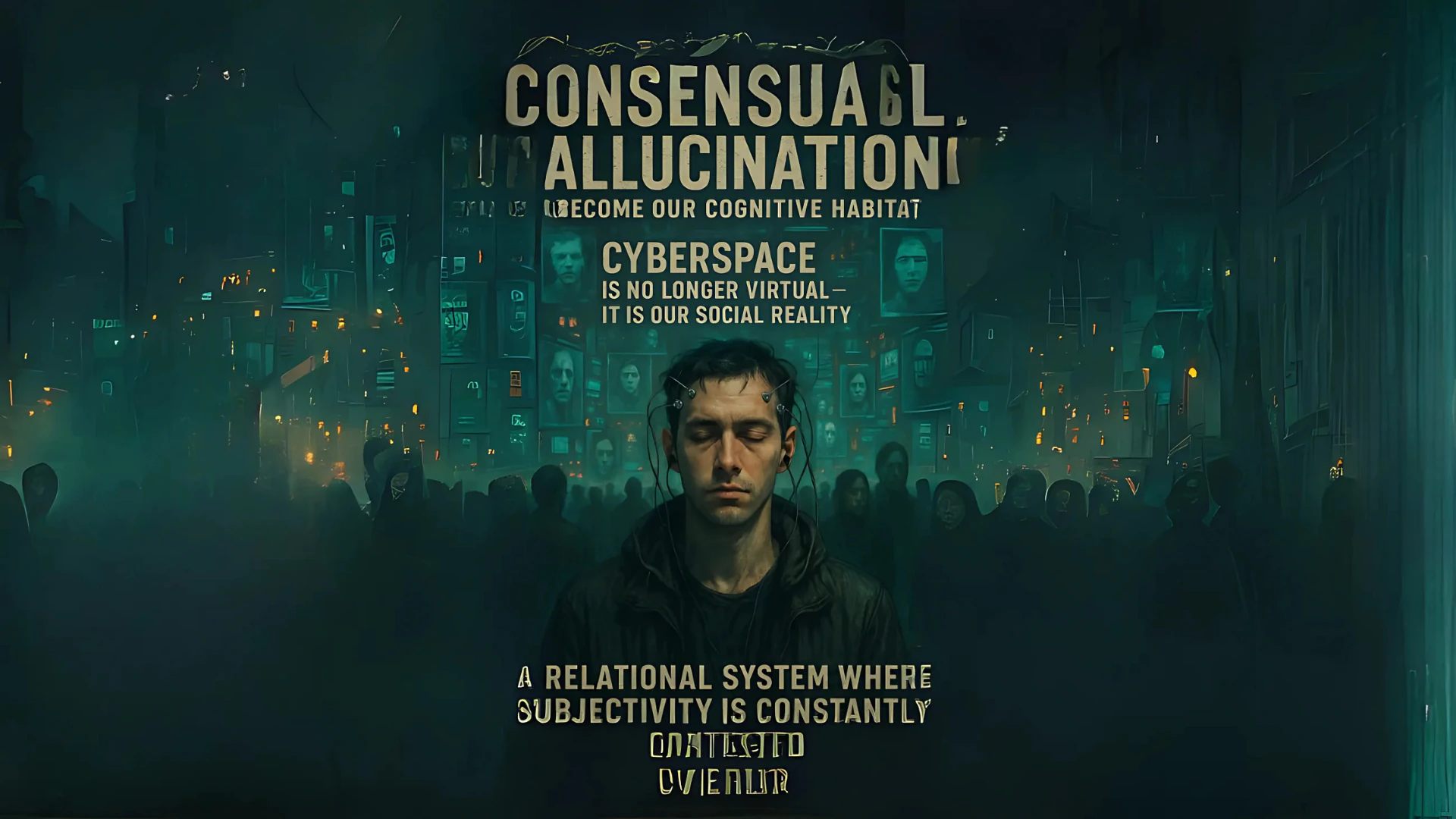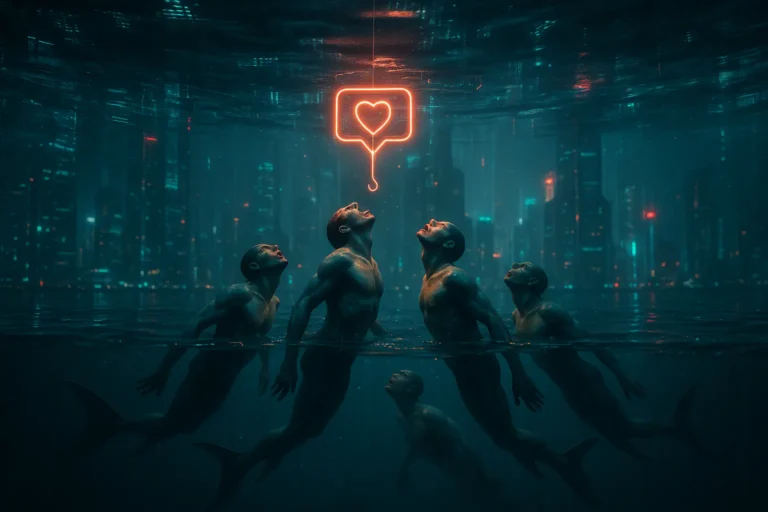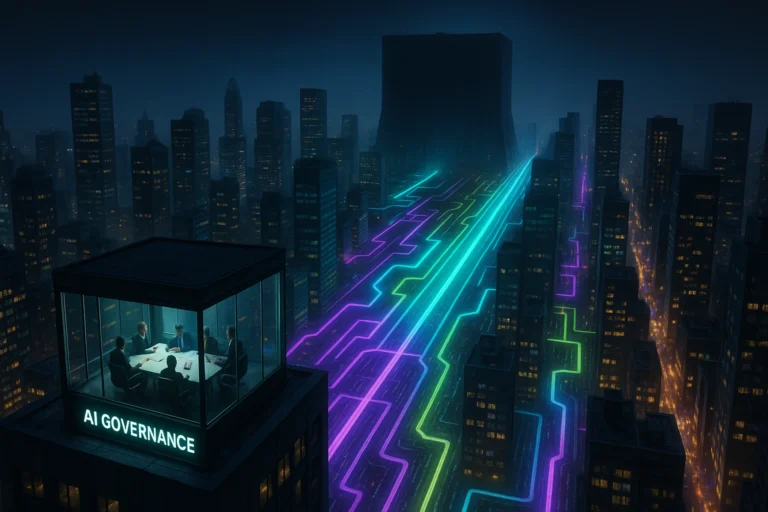Sorveglianza digitale
1.L’illusione della scelta
Viviamo in ambienti digitali che promettono libertà, personalizzazione. Ma ogni gesto è sotto controllo. Ogni volta che scrolliamo un feed, clicchiamo su un link o ascoltiamo una playlist suggerita da un algoritmo, dobbiamo chiederci: è davvero una nostra scelta? O stiamo semplicemente recitando un copione costruito altrove?
“Il potere non si prende, si esercita… e si esercita in una rete di relazioni.” — Foucault, Microfisica del potere, 1977
Oggi quella rete è infrastrutturale e simbolica: ogni scroll, like, commento viene registrato, profilato, trasformato in dati.
2. Il panopticon digitale e l’autosorveglianza attiva
Foucault reinterpreta il modello benthamiano del panopticon: un sistema di sorveglianza che dirige i comportamenti attraverso l’invisibilità del sorvegliante. Oggi, il «panopticon digitale» si manifesta attraverso infrastrutture di tracciamento continuo, capaci di monitorare ogni nodo della nostra cittadinanza digitale: corpi, dati, interazioni.
“Il potere mediale non si esercita in modo diretto, ma attraverso dispositivi di selezione, normalizzazione e costruzione di ciò che è dicibile e visibile.” — Colombo, Il potere socievole, 2013
I dati generati, i nostri comportamenti, diventano oggetti di controllo e merce all’interno delle logiche capitalistiche delle piattaforme.
3. Identità performativa: Mead, Turkle e la quantificazione del sé
Mead sostiene che l’identità emerge nell’interazione con l’“altro generalizzato”:
“Il Sé emerge dal processo sociale, non è dato ma costruito attraverso l’interazione.” — Mead, Mind, Self and Society, 1934
Oggi, l’altro generalizzato è l’algoritmo. La nostra identità digitale è costruita attraverso feedback strategici come like, condivisioni, visualizzazioni. L’interazione diventa performativa e asservita alla visibilità.
Sherry Turkle, in Life on the Screen (1995), evidenzia come gli ambienti digitali siano luoghi di continua sperimentazione identitaria. Identità multiple, temporanee, frammentate — l’io perde confini. Il narcisismo identitario e l’esposizione ai flussi informativi eliminano la stabilità del sé, mentre il corpo diventa un oggetto performato, temporaneo e mercificato. In questo contesto, la soggettività è quantificata e potenzialmente sfruttata economicamente.
4. Mimetismo e rituali algoritmici: Lévi-Strauss e la cultura della performance
Claude Lévi-Strauss ha mostrato come le narrazioni e i miti organizzino coesione sociale e identità. Nella blogosfera, nei meme e nei trend social, queste narrazioni emergono come rituali digitali replicativi, che modellano il comportamento collettivo:
“La logica mediale non si limita a trasmettere messaggi: essa costruisce cornici cognitive, organizza l’accesso al mondo.” — Colombo, La cultura sottile, 1998
In questi rituali, il mimetismo digitale diventa conformismo: si replica ciò che “funziona”, secondo le logiche algoritmiche. La devianza o l’espressione divergente non viene punita, ma resa irrilevante.
5. Biopotere e parresia nella società algoritmica
Foucault definisce il biopotere come il potere che regola la vita stessa delle popolazioni, gestendo flussi vitali. Nella rete digitale, il biopotere è incarnato dagli algoritmi che gestiscono la visibilità, la viralità, la realtà stessa:
“Il potere produce realtà; produce domini di oggetti e rituali di verità.” — Foucault, Sorvegliare e punire, 1975
In questa architettura, la parresia (parlare liberamente, pubblicamente, veritieramente) viene marginalizzata. La comunicazione è guidata da logiche economiche e di engagement, non da spirito democratico.
Colombo esplora questo tema in Controllo, identità, parresìa (2012), dove analizza come il discorso libero sia ostacolato dalle strutture algoritmiche della piattaforma.
6. Conclusione: Resistere alla soggettivazione algoritmica
Resistere oggi significa rallentare, creare spazi di pensiero non calcolabile, rigenerare forme autonome di comunicazione e narrazione.
“Bisogna promuovere un’ecologia dei media che riduca l’inquinamento simbolico delle piattaforme e riapra spazi di autenticità e dialogo.” — Colombo, Ecologia dei media, 2020
La libertà non è l’assenza di controllo, ma la capacità di resistere — non conformarsi — alle logiche dominanti del potere digitale. L’autonomia diventa pratica attiva, consapevole, critica.
Bibliografia
- Michel Foucault, Sorvegliare e punire, 1975
- Michel Foucault, Microfisica del potere, 1977
- George H. Mead, Mind, Self and Society, 1934
- Claude Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, 1958
- Sherry Turkle, Life on the Screen, 1995
- Fausto Colombo, Il potere socievole, 2013 (Vita e Pensiero)
- Fausto Colombo, La cultura sottile, 1998
- Fausto Colombo, Controllo, identità, parresìa, 2012 (voce tematica su Wikipedia)
- Fausto Colombo, Ecologia dei media, 2020 (Vita e Pensiero)